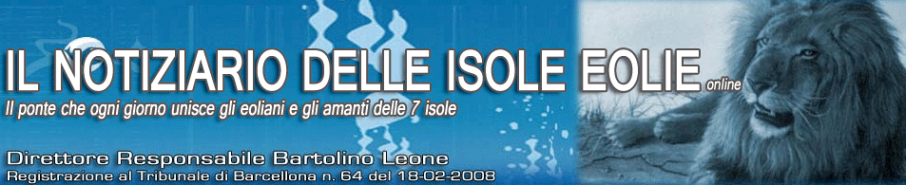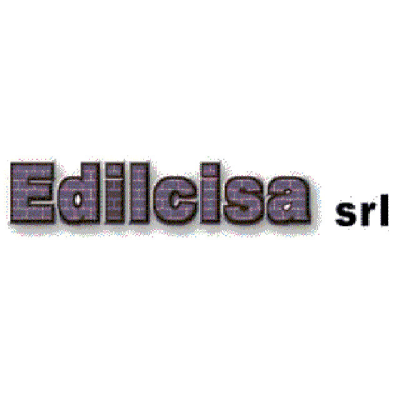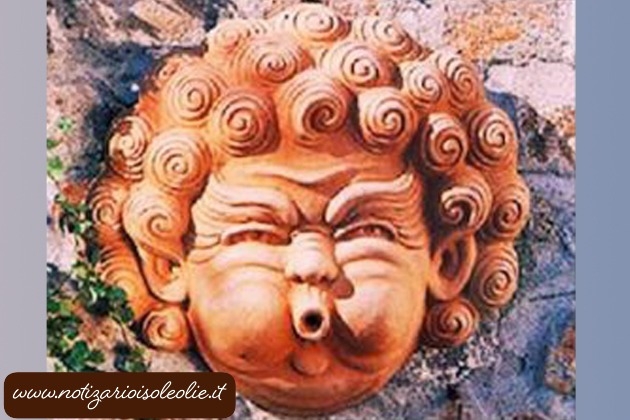Da Melbourne in linea Marcello Saija 'Parlare di mafia in Sicilia è ormai diventato semplice'
di Marcello Saija
Parlare di mafia in Sicilia è ormai diventato semplice. La Mafia non ha più nulla di misterioso. Si può dire che la grande quantità di studi fatti è servita a conoscerla e a lottarla. Non voglio dire che essa è sconfitta ma certo la conoscenza della sua storia e gli avvenimenti degli ultimi trent’anni l’hanno resa più debole. Tutti hanno capito finalmente che la mafia non ha nulla di nobile ed è soltanto un’associazione di malfattori. Conoscere la sua storia e diffonderla è quindi il modo migliore di combatterla.
Non la pensano così i discendenti degli emigrati siciliani in America e in Australia che hanno invece quasi paura a parlarne. Comprendo questo stato d’animo perché so che, quando un siciliano si presenta come tale si sente spesso dire:” Allora sei mafioso”.
Riteniamo tuttavia che sia sbagliato nascondere la storia della Mafia, noi pensiamo che più la si conosce più le si sottrae il consenso. Ed è per questa ragione che qui molto brevemente vi racconterò come nasce la Mafia e come si evolve sino ad oggi, tentando di spiegare anche perché sono successi gli avvenimenti che tra poco vedrete raccontati nella piece teatrale.
Prima del 1812 la Sicilia era fatta per una parte da feudi grandi abitati dai contadini e governati dai baroni che pagavano le tasse al Re e per l’altra parte, da terre abitate da contadini ma governate dai giurati delle città demaniali che anche loro raccoglievano e pagavano le tasse al Re. In entrambi i casi i contadini godevano dei cosiddetti diritti promiscui che erano necessari per garantire la loro sopravvivenza: coltivavano in comune piccoli appezzamenti di terra; raccoglievano legna nei boschi; avevano il permesso di prendere l’acqua e di usare quella dei ruscelli per lavare i panni; gli abitanti di Lipari in particolare avevano il diritto di scavare la pomice per fare i tetti delle case e così via.
La riforma del 1812 ispirata dagli Inglesi che in quel momento governavano la Sicilia abolisce i diritti promiscui e trasforma i feudi in proprietà dei baroni sostenendo, in omaggio alla cultura capitalista affermatasi in Inghilterra, che in questo modo chi voleva la terra poteva comprarsela.
Era una sciocchezza perché i contadini non avevano i soldi per comprare le terre e quelle che si vendevano passavano di mano in mano tra i baroni. Fu così che si venne a creare una situazione nella quale l’1% della popolazione possedeva il 99% delle terre produttive.
I baroni grandi proprietari non curavano direttamente le loro terre. Le davano in “gabella”, cioè le affittavano richiedendo in anticipo i soldi dell’affitto. I gabelloti (così si chiamavano gli affittuari) assoldavano i contadini pagandoli il meno possibile, e potevano farlo perché l’offerta di braccia di lavoro era davvero grande. Moltissimi quindi venivano esclusi e condannati alla fame insieme con le loro famiglie. La situazione era diventata esplosiva e il pericolo della rivolta sociale era alle porte. Così la struttura dei gabelloti diventò un’organizzazione violenta che serviva a contenere la rabbia dei contadini.
QUESTA È L’ORIGINE DELLA MAFIA: Un’organizzazione di malavitosi a tutela degli interessi delle classi dominanti: aristocratici proprietari e gabelloti affittuari.
Questi ultimi guadagnavano assai più dei proprietari che invece spendevano le loro rendite nelle grandi capitali europee. A poco a poco quindi i gabelloti comprarono dai padroni buona parte delle loro terre diventando loro i proprietari più grandi. Si pensi che al momento dell’unificazione d’Italia i proprietari di terre superiori a cento ettari erano passati dai 692 del 1812 ai quasi 11000 del 1861.
Con la creazione del Regno di Italia (1861) è proprio una parte di ex gabelloti, ormai ricchi, che conquistano il potere politico diventando deputati e senatori. Naturalmente vengono elette anche persone che con la Mafia non c’entrano nulla. Tuttavia, i parlamentari ex gabelloti sono tanti e questo fenomeno rappresenta il primo vero collegamento tra lo Stato e la Mafia siciliana.
Quando costoro diventano parlamentari non sono più membri dell’organizzazione mafiosa ma uomini d’affari che operano nelle città siciliane. Hanno però il potere di dirigere la manovalanza mafiosa procurando loro occasioni di guadagno offrendo appalti pubblici. In compenso si garantiscono così il consenso elettorale che serve loro per continuare a governare.
Ed è questa la situazione che permane negli anni. Non solo durante l’esperienza dello Stato liberale (1861-1922); ma anche (in forme che non ho il tempo di spiegarvi) durante il Fascismo (1922-1943).
Si ha una formidabile ripresa nel secondo dopoguerra repubblicano, quando le grandi masse di contadini che non riescono più a vivere nelle campagne si spostano nelle città. In questa situazione, a causa del suffragio, diventato ormai universale, la Mafia diventa per molti politici indispensabile a garantirsi l’elezione in Parlamento. Questo consolida fortemente il rapporto tra lo Stato e la Mafia.
Con la crescita della coscienza popolare contro la mafia, i politici che la usano diventano una minoranza anche se spesso occupano posti di comando importanti nell’organizzazione dello Stato. In queste condizioni anche se l’opinione pubblica contraria alla Mafia cresce, lo Stato non riesce a condannarla nei processi. Adotta spesso soluzioni di compromesso come quella di inviare i mafiosi in soggiorno obbligato in posti lontani dalla Sicilia, oppure nelle piccole Isole dove lo Stato ritiene di non avere grandi reazioni da territori spopolati dall’emigrazione.
Ed invece si sbagliano! Ed è proprio quello che accade a Filicudi e tra poco lo vedrete.
Come finisce questo rapporto tra Stato, Mafia e popolazione civile lo analizzeremo dopo attraverso le vostre domande. Ora godetevi lo spettacolo
La capacità di pilotare la Mafia da parte dei colletti bianchi, cioè dei Politici affaristi dura fino a quando essa non trova autonomamente un modo di guadagnare differente e molto più lucroso di quello degli appalti pubblici che gli offrivano i politici: il mercato della droga.
A quel punto si inverte il modello di indipendenza a non sono più i politici che guidano la mafia ma la mafia che si crea da sola i suoi quadri politici. Siamo ai tempi di Ciancimino sindaco di Palermo e di Salvo Lima deputato al Parlamento, costoro sono membri organici della Cupola mafiosa.
Le indagini dei Magistrati Falcone e Borsellino scoperchiano la pentola. Lo Stato riesce finalmente a processare i capi della Mafia che reagiscono facendo saltare in aria Falcone e assassinando Borsellino.
Siamo allo scontro frontale tra Stato e Mafia. Qualcuno vuole ancora trattare per trovare un compromesso. Ormai però l’opinione pubblica in Sicilia è contro la Mafia e finalmente lo Stato ha la forza di reagire. Il patto di non belligeranza tra Stato e Mafia si rompe, la Mafia non gode più delle protezioni dell’apparato dello Stato. I pentiti che rivelano i segreti della mafia si moltiplicano. L’opinione pubblica toglie il consenso alle cosche. Certo, la mafia continua ad esserci ma oggi è isolata come non è mai stata nella sua storia.